QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024
Scienza e Farmaci
Recidiva di cancro dell’ovaio. Il rechallenge con bevacizumab dimezza il rischio di progressione di malattia
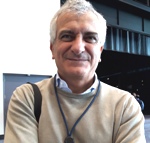 3 giugno - Sono i risultati del MITO-B16 uno studio internazionale indipendente, coordinato dall’Italia e presentato al congresso degli oncologi americani. Al momento il farmaco anti-angiogenetico viene somministrato una sola volta, in genere in prima linea, nella storia di malattia delle pazienti con tumore dell’ovaio. Questi risultati ne dimostrano l’efficacia anche in caso di risomministrazione e potrebbero portare a modificare le attuali linee guida.
3 giugno - Sono i risultati del MITO-B16 uno studio internazionale indipendente, coordinato dall’Italia e presentato al congresso degli oncologi americani. Al momento il farmaco anti-angiogenetico viene somministrato una sola volta, in genere in prima linea, nella storia di malattia delle pazienti con tumore dell’ovaio. Questi risultati ne dimostrano l’efficacia anche in caso di risomministrazione e potrebbero portare a modificare le attuali linee guida.
Il bevacizumab, un antiangiogenetico, è approvato per il trattamento del tumore dell’ovaio, nelle pazienti che non abbiano ricevuto in precedenza questo trattamento. Nella storia della malattia di una donna con cancro dell’ovaio, insomma, il farmaco, secondo le attuali linee guida è previsto solo per un’unica linea di trattamento. Ma è certo che non potrebbe funzionare anche nel caso di una somministrazione successiva, ad esempio in caso di progressione della malattia?
È la risposta alla quale cercherà di rispondere lo studio MITO-B16, che sarà presentato a Chicago, nell’ambito del congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) il 5 giugno. “Questo studio – commenta il professor Sandro Pignata, direttore dell’oncologia uro-ginecologica, Istituto Pascale di Napoli e presidente del gruppo MITO (Multicenter Italian Trial Ovarian Cancer), creato 20 anni fa – è anche una storia di successo di una partnership pubblico-privato, tra Istituto Pascale di Napoli, Roche, AIRC e AIOM e rappresenta un esempio virtuoso di ricerca indipendente”.
Il MITO-B16 ha arruolato 405 pazienti con recidiva di cancro dell’ovaio in 4 nazioni (100 in Francia, 17 in Svizzera, 11 in Grecia e le restanti 277 in Italia), per valutare se l’aggiunta di bevacizumab ad un regime di chemioterapia a base di platino fosse in grado di prolungare la PFS nelle pazienti con una recidiva di cancro del’ovaio già trattate in precedenza (cioè in prima linea) con questo farmaco.
Le pazienti arruolate nello studio sono state randomizzate a due regimi di trattamento: sei cicli di chemioterapia (carboplatino/paclitaxel o carboplatino/gemcitabina o carboplatino/PLD) con o senza l’aggiunta di bevacizumab, somministrato insieme alla chemioterapia, quindi proseguito come terapia di mantenimento, fino a progressione. Endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS).
Dopo un follow-up medio di 20,3 mesi, si sono verificati 304 eventi di PFS e 147 decessi. La PFS mediana è risultata di 11,8 mesi nelle pazienti trattate con l’associazione chemioterapia – bevacizumab, contro 8,8 mesi di quelle trattate con la sola chemioterapia (HR 0,51). Tra gli effetti collaterali registrati, sono risultati più frequenti nel gruppo bevacizumab, l’ipertensione grave (27,5% contro il 9,7 del gruppo chemioterapia) e la proteinuria (4% contro 0%).
Lo studio dimostra che nelle pazienti con recidiva di cancro dell’ovaio, già trattate in prima linea con bevacizumab, aggiungere di nuovo l’antiangiogenetico alla chemioterapia comporta un prolungamento significativo della PFS.
“Il MITO-16B – commenta il professor Sandro Pignata – dimostra che bloccare l’angiogenesi in varie linee di trattamento migliora la prognosi. Le implicazioni dei risultati di questo studio per la pratica clinica sono che nelle pazienti con recidiva di malattia, già trattate con bevacizumab in prima linea (cioè il 60% delle pazienti italiane), tornare a somministrare questo anti-angiogenetico insieme alla chemioterapia si traduce in un netto beneficio sulla PFS”.
Un’altra parte di questa ricerca, lo studio traslazionale, coordinato dal dottor Gennaro Daniele, Unità di Sperimentazioni Cliniche dell’Istituto Pascale di Napoli , cercherà di individuare dei biomarcatori che permettano di selezionare le donne con maggiori chance di risposta al trattamento.
“Va però detto – conclude il professro Pignata – che, per quanto favorevoli questi risultati, le pazienti italiane non potranno utilizzare il bevacizumab per la seconda volta, in quanto non rimborsato per questa indicazione dall’AIFA. Ma anche su questo abbiamo la speranza che qualcosa possa cambiare. Anche perché a breve questa nuova indicazione (il cosiddetto rechallenge) verrà inserita nelle linee guida americane ed europee.”
Maria Rita Montebelli
È la risposta alla quale cercherà di rispondere lo studio MITO-B16, che sarà presentato a Chicago, nell’ambito del congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) il 5 giugno. “Questo studio – commenta il professor Sandro Pignata, direttore dell’oncologia uro-ginecologica, Istituto Pascale di Napoli e presidente del gruppo MITO (Multicenter Italian Trial Ovarian Cancer), creato 20 anni fa – è anche una storia di successo di una partnership pubblico-privato, tra Istituto Pascale di Napoli, Roche, AIRC e AIOM e rappresenta un esempio virtuoso di ricerca indipendente”.
Il MITO-B16 ha arruolato 405 pazienti con recidiva di cancro dell’ovaio in 4 nazioni (100 in Francia, 17 in Svizzera, 11 in Grecia e le restanti 277 in Italia), per valutare se l’aggiunta di bevacizumab ad un regime di chemioterapia a base di platino fosse in grado di prolungare la PFS nelle pazienti con una recidiva di cancro del’ovaio già trattate in precedenza (cioè in prima linea) con questo farmaco.
Le pazienti arruolate nello studio sono state randomizzate a due regimi di trattamento: sei cicli di chemioterapia (carboplatino/paclitaxel o carboplatino/gemcitabina o carboplatino/PLD) con o senza l’aggiunta di bevacizumab, somministrato insieme alla chemioterapia, quindi proseguito come terapia di mantenimento, fino a progressione. Endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS).
Dopo un follow-up medio di 20,3 mesi, si sono verificati 304 eventi di PFS e 147 decessi. La PFS mediana è risultata di 11,8 mesi nelle pazienti trattate con l’associazione chemioterapia – bevacizumab, contro 8,8 mesi di quelle trattate con la sola chemioterapia (HR 0,51). Tra gli effetti collaterali registrati, sono risultati più frequenti nel gruppo bevacizumab, l’ipertensione grave (27,5% contro il 9,7 del gruppo chemioterapia) e la proteinuria (4% contro 0%).
Lo studio dimostra che nelle pazienti con recidiva di cancro dell’ovaio, già trattate in prima linea con bevacizumab, aggiungere di nuovo l’antiangiogenetico alla chemioterapia comporta un prolungamento significativo della PFS.
“Il MITO-16B – commenta il professor Sandro Pignata – dimostra che bloccare l’angiogenesi in varie linee di trattamento migliora la prognosi. Le implicazioni dei risultati di questo studio per la pratica clinica sono che nelle pazienti con recidiva di malattia, già trattate con bevacizumab in prima linea (cioè il 60% delle pazienti italiane), tornare a somministrare questo anti-angiogenetico insieme alla chemioterapia si traduce in un netto beneficio sulla PFS”.
Un’altra parte di questa ricerca, lo studio traslazionale, coordinato dal dottor Gennaro Daniele, Unità di Sperimentazioni Cliniche dell’Istituto Pascale di Napoli , cercherà di individuare dei biomarcatori che permettano di selezionare le donne con maggiori chance di risposta al trattamento.
“Va però detto – conclude il professro Pignata – che, per quanto favorevoli questi risultati, le pazienti italiane non potranno utilizzare il bevacizumab per la seconda volta, in quanto non rimborsato per questa indicazione dall’AIFA. Ma anche su questo abbiamo la speranza che qualcosa possa cambiare. Anche perché a breve questa nuova indicazione (il cosiddetto rechallenge) verrà inserita nelle linee guida americane ed europee.”
Maria Rita Montebelli
3 giugno 2018
© QS Edizioni - Riproduzione riservata